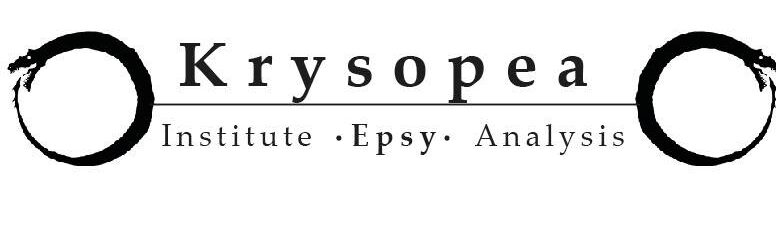Polaroid in bianco e ocra
di Valentina Zinzula
Sono stanca, la pancia mi pesa e non riesco più a muovermi veloce come vorrei. Meno male che tra poco nascerà. La dottoressa è molto gentile, ha chiesto da quanto tempo vivo qui, dice che parlo benissimo l’italiano. Ha controllato ancora il battito, mi ha sorriso e ha domandato “Come chiamerà la sua bambina?”. Le sorrido anche io, orgogliosa della mia scelta. Ecco i suoi calcetti, piace anche a lei. Socchiudo gli occhi e il mio pensiero viaggia nel tempo, nei frammenti di vita sparsi nella memoria, come fotogrammi slegati che mi conducono a un unico pensiero. La mia Mogadiscio.
Avevo sei anni quando i miei genitori e mia sorella morirono nell’attentato al mercato. L’immagine dei loro corpi freddi, distesi vicini, di notte mi sveglia ancora. Ero rimasta sola, e fu allora che mia zia decise di portarmi con lei in Italia. “Devi prendere quella fotografia”, le dissi mentre mi preparava la valigia. “Cosi la mia mamma starà con me, e anche la mia amica”. Le indicai una polaroid scattata qualche mese prima, conservata tra i vestiti di mia madre. È l’unica immagine che ho di lei. Nascosta dietro la sua gonna bianca ci sono io e vicino a me, inginocchiata nei suoi pantaloni ocra, c’è la giornalista che me l’aveva regalata. Mi sorride e mi porge la mano.
Dall’inizio della guerra, ogni giorno scorreva col timore che fosse l’ultimo. In quegli anni arrivarono tanti soldati per ristabilire l’ordine, per offrirci protezione, ma a me i loro fucili facevano paura. C’erano dottori che ci aiutavano e giornalisti che venivano da ogni parte del mondo. C’erano gli uomini bianchi con i soldi, che venivano per fare affari, ma quali fossero gli affari io non lo sapevo.
E poi c’era una giornalista italiana, quella della foto, diversa dalle altre che avevo visto. Era una donna umile, che ci guardava con curiosità e rispetto, che aveva scelto di studiare la nostra lingua. Una donna tenace, voleva che la voce dei deboli e dei giusti venisse ascoltata. Quando arrivò in Somalia per la prima volta vivevamo la fase più cruenta della guerra. La vedevamo spesso tra le strade di Mogadiscio, veniva in città insieme all’uomo con la telecamera. Voleva seguire la guerra sul campo ed era l’unica che stava in mezzo alla folla senza troppi problemi. Era una di noi, indossava sempre i sandali, come a dire “sono tranquilla qui, come fossi a casa mia”. Quando diventammo amiche mi portò dal suo paese un braccialetto con tante perline e dei campanelli. Fu il regalo più bello della mia vita. Mi piaceva il suono che faceva e mi divertivo a salutare tutti agitando la mano e saltellando. Lei rise, il viso le si illuminò e ci abbracciammo forte. Una sera la vidi in spiaggia, con l’espressione un po’ triste. Chissà a cosa pensava quando stava seduta sulla riva, ad osservare il mare con lo sguardo perso verso l’orizzonte. Stava lì, in silenzio. Forse pensava ai suoi genitori e a quanto fosse lontana la sua casa, forse che in fondo, il mare, aveva lo stesso odore che sentiva quando passeggiava sulla spiaggia in Italia. Forse immaginava quante navi stessero solcando le onde in quel momento, le stesse navi per cui faceva tante domande. Ora la stringerei forte per dirle “andrà tutto bene”, ma allora ero soltanto una bambina e avevo io tanto bisogno di un abbraccio. In realtà poi, le cose non andavano bene affatto.
Gli aiuti umanitari faticavano a raggiungerci, i contingenti militari avevano ricevuto l’ordine di abbandonare la città. Si ritirarono uno dopo l’altro. Anche quello italiano era partito, e tutti i giornalisti erano stati richiamati per la loro sicurezza. Non tutti, perché lei rimase insieme al signore con la telecamera. Li vidi andare via con la macchina.
Ricordo bene quel giorno, era un pomeriggio caldo. Gli attacchi erano frequenti e nelle strade non girava molta gente.
Una camionetta carica di odio fu l’artefice dell’esecuzione. Improvvisamente si fermò tagliando la strada all’altra vettura. Gli spari imposero il silenzio.
Non ricordo quanti erano, ricordo soltanto che il mio braccialetto tremava mentre stringevo le mani contro la testa per tapparmi le orecchie. Ricordo che il braccialetto si ruppe e cadde a terra, mentre mia madre mi afferrava il braccio per scappare più veloci. La camionetta non c’era più. Poco dopo vidi correre tanta gente in direzione opposta alla mia, verso gli spari. Mamma invece non si fermò finché non arrivammo a casa, al sicuro.
In un giorno di guerra qualunque il vento soffiò più forte su Mogadiscio. Alzò la polvere, scosse le coscienze. La giornalista e il suo operatore erano morti, lontano dalla famiglia e dalle loro certezze, in una terra che li aveva accolti per poi tradirli. Mi dissero che la mia amica si era addormentata in quella macchina, era piegata sul sedile con la testa tra le mani e la paura nel cuore. Il sangue le sporcava i lunghi capelli biondi. Si era addormentata e non si svegliò più.
“Ha scelto il nome che darà alla sua bambina?” La voce della dottoressa mi riporta al presente.
È tempo di rimettere i frammenti in un cassetto, riporre con cura ogni ricordo. La polaroid, il braccialetto ballerino, il mare, la mia mamma e lei, la mia amica.
“Si.” le dico riaprendo gli occhi “La chiamerò Ilaria”.